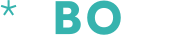Bologna, estate. Il momento ideale per parlare di… morte! E non per il caldo (che comunque…) ma per raccontare una storia, quella di Leonardo Fabbretti e della sua battaglia per recuperare i ricordi digitali del figlio prematuramente scomparso, in altre parole per accedere all’eredità digitale di suo figlio.
Non ci va molto a genio parlare di morte (e anche su questo ritorneremo), ma quello dell’eredità digitale è un argomento troppo importante per essere trascurato, tant’è che Francesco Perlini e Nicola Vasini ci hanno fatto un podcast, Digital Requiem, edito da Il Post e valsogli recentemente due argenti (miglior documentario e miglior sceneggiatura originale) all’Italian Podcast Awards.

Nicola Vasini e Francesco Perlini
Francesco e Nicola, entrambi bolognesi, autore e copywriter il primo, giornalista il secondo, partono dalla storia di Leonardo Fabbretti per trattare le implicazioni sociali, etiche e non solo, dell’eredità digitale, confezionando un documentario di grande interesse.
Il tema portante di Digital Requiem è la morte nell’era digitale. La morte, come sottolineate anche nel podcast, è un argomento che la società contemporanea ha progressivamente rimosso da ogni discorso, rendendolo sostanzialmente tabù. Partirei da qui, perché a vostro avviso è importante o interessante parlarne?
Francesco: Il contesto culturale occidentale deriva da un Novecento che ha sparso molto sangue, e al contempo ha rifiutato la morte umana più di qualsiasi altra cultura: si è focalizzato su un’iper-performatività che non tollera pause né vuoti, su una sanità che ci fa morire tardissimo e lontano dalle mura di casa, su un Dio-denaro che chiama a sé chi consuma e produce, non chi si addormenta. Con questo retroterra storico, è più faticoso e insolito affrontare il tema del lutto, della perdita e della memoria di chi non c’è più, al punto che sentir parlare di morte può rovinarci la giornata… credo che non lo farebbe altrettanto se ne parlassimo un pochino di più, ogni tanto, senza ossessioni. Parlarne ha una funzione sia preventiva che curativa: ci aiuta a prendere confidenza con un tema che ci ha riguardato, ci riguarda o ci riguarderà tutti.
Nicola: Credo anch’io che questa tendenza a rimuovere la morte, a non pensarla, a tenerla lontana, ci faccia più male che bene. Pensate al solo chiedere a qualcuno come sta dopo un lutto: nominare la morte o parlare apertamente di dolore mette a disagio. Diventa imbarazzante. Eppure, in certi casi, proprio quando si soffre, si ha bisogno del contrario: di essere ascoltati, di sentirsi chiedere “come stai?”. Rimuovere la morte dal discorso o “addolcirla” a tutti i costi – penso alle varie perifrasi, metafore, eufemismi – ci rende più difficile accettarla e considerarla parte della vita.
Altro aspetto centrale è appunto il digitale, e in particolare l’eredità digitale che ci si lascia alle spalle. Come cambia l’eredità quando diventa digitale? Provo a fare un esempio: un’eredità analogica come una lettera implica uno sforzo produttivo, qualcuno che coscientemente si mette a scriverla sapendo che quel documento potrà sopravvivergli. Nel digitale invece la produzione è talmente vasta e rapida da essere spesso inconscia: scrivendo un Whatsapp non ci si mette a pensare al fatto che tra 30 anni qualcuno potrebbe ritrovarsi a leggerlo. Cosa ne pensate?
Nicola: Non credo che la produzione non pianificata sia una peculiarità dell’eredità digitale: scarabocchi, disegni, scritte, collage, sono tutte cose semplici, nate senza l’intenzione che durassero ma, in fondo, tracce della nostra esistenza, del nostro passaggio. Magari per noi sono senza senso, però, che l’eredità sia analogica o digitale, un giorno qualcuno potrebbe volerla ritrovare, potrebbe trarre conforto nell’averla.
Francesco: Mi viene in mente il poeta latino Orazio; già famoso e vicino alle sfere del potere scrisse che non sarebbe mai morto del tutto grazie all’immortalità dei suoi versi – e infatti eccoci qui a ricordarlo, duemila anni dopo. La rivoluzione digitale tende ad allontanarci da questa consapevolezza rispetto alla nostra eredità, portandoci a produrre costantemente dati, sequenze di zero e uno conservate nelle memorie dei dispositivi, o su server dislocati forse in mezzo ai deserti o sotto il mare. Ma vorrei piuttosto concentrarmi sui dati che produciamo in modo consapevole: le foto, i pensieri scritti, i messaggi vocali… per quanto riguarda loro, fondamentalmente sta a noi decidere se qualcuno possa ereditarli dopo che spariremo. Se la cosa ti spaventa, puoi cancellare più che puoi – mai tutto. Se la cosa ti conforta, puoi trasmettere parte del tuo patrimonio digitale – mai tutto. Di cosa e come parliamo nel podcast, tra le altre cose.

Quello dell’eredità digitale è un argomento con forte impatto sociale e la vostra scelta di trattarlo non solo da una prospettiva narrativa, ma anche da quella legale od etica (coinvolgendo talvolta speaker specialisti “tecnici” e accademici) rende Digital Requiem un podcast molto “concreto”. Preparandolo, vi ponevate (anche) un obiettivo sociale? Cercavate di suscitare reazioni particolari nell’ascoltatore?
Nicola: Sì, un obiettivo sociale c’è, seppure in forma narrativa e senza dare un giudizio morale. Volevamo offrire all’ascoltatore una mappa, un percorso dentro la complessità del tema dell’eredità digitale.
C’è chi, per motivi legittimi, è fermamente contrario all’accesso ai dispositivi delle persone defunte, come emerso anche nel podcast, ci sono implicazioni legate alla privacy di terzi che vanno rispettate. Dall’altro lato, però, ci si confronta con l’enorme patrimonio affettivo, biografico e spesso anche pratico che i nostri dispositivi contengono. E allora, in assenza di scelte consapevoli prese in vita, cosa si fa? In questo senso, più che dare risposte, volevamo sollevare domande; aiutare le persone a formarsi un’opinione e, magari, a immaginare cosa fare se si trovassero in situazioni simili.
Francesco: Sono d’accordo con Nicola. Le mie storie preferite, infatti, sono quelle utili: lasciano strumenti, nozioni, sensibilità o spirito critico da reinvestire nella propria vita. Digital Requiem segue questo approccio, cercando ad esempio di farci capire come funzionano le leggi degli Stati, le regole delle aziende informatiche, cosa già dicono e cosa secondo noi potrebbero iniziare a dire. Abbiamo volutamente cercato pareri critici e tecnici per offrire all’ascoltatore qualcosa di utile e interessante, oltre alla narrazione.
Nicola: Per me il senso del giornalismo è anche questo: attivare consapevolezza; consapevolezza che possa anche tradursi in azioni concrete. Se Digital Requiem ha contribuito a far nascere conversazioni su cosa fare dei nostri dati, su come vogliamo essere ricordati, su come affrontare la morte anche dal punto di vista digitale, allora abbiamo toccato l’obiettivo. E ne sono davvero felice.
Mi permetto una domanda personale: come vi ponete rispetto alla vostra eredità digitale personale? Lavorare su Digital Requiem ha in qualche modo cambiato o stimolato il vostro pensiero?
Nicola: In famiglia ne abbiamo parlato, ma sono lontano da farmi un’idea definitiva. Per ora, il mio desiderio è che i miei familiari possano avere accesso ai miei dispositivi e recuperare tutto quel materiale: idee, progetti incompiuti, note, foto e video, ovviamente nel rispetto dei limiti che abbiamo concordato. Mi piacerebbe che potessero esplorare liberamente la mia eredità digitale, anche da un punto di vista creativo e che decidano loro cosa conservarne, trasformare o eventualmente lasciar andare.
Data la natura molto delicata e personale della domanda, Francesco ha preferito non rispondere (ndr).
Arrivati a questo punto, credo sia il caso di alleggerire un po’ il clima. Vorrei chiedervi se, secondo voi, dobbiamo aspettarci un futuro a la Black Mirror di vita digitale dopo la morte?
Francesco: Esistono già servizi che tentano di “riportare in vita” i nostri morti, attraverso simulazioni di chatbot o sintesi vocale: per essere credibili, devono basarsi su dati pubblici e privati dei nostri cari, che noi scegliamo di offrire.
In Black Mirror, nell’episodio “Be right back”, la protagonista utilizza un servizio di questo tipo ma alla fine – spoiler – si pente amaramente di aver ordinato un robot sostitutivo del compagno morto. La conclusione di quella storia è che le macchine sono create con scopi ambiziosi, ma risultano goffe, imprecise, incapaci di simulare gli umani come davvero li conosciamo e quindi li desideriamo, compresi i problemi, i comportamenti impulsivi, fino alla sensazione tattile della carne o i cattivi odori. Ma che ne sappiamo di come evolverà la tecnologia?
Per ora sospendo il giudizio fino agli esiti di ricerche autorevoli. Al fianco di fantasmi, i vivi vivrebbero meglio? O resterebbero infognati in una negazione tossica della perdita? Mi sembra strano immaginare un amico che si presenta all’aperitivo con un robot indistinguibile dal partner perso in un incidente, ma se la ricerca dimostrerà che questo può fargli bene farò il possibile per vedere la cosa di buon occhio; magari finirò con l’ordinare anche io il robot di mia nonna per ascoltare le ninne nanne che mi cantava quando ero piccolo! Meglio riparlarne tra qualche annetto!
Nicola: Rifacendomi all’episodio di Black Mirror, è assolutamente plausibile che i nostri dati, messaggi, foto, voce possano essere usati per “ricreare” una persona e, come già diceva Francesco, queste tecnologie in parte già esistono. Credo però che l’episodio ponga una questione non tanto tecnologica ma di natura umana: Quanto vogliamo davvero tenere in vita chi non c’è più, in una maniera così artificiale? E a che prezzo emotivo e relazionale? Come dicevamo prima, cosa ci perdiamo non accettando la morte come parte della vita?
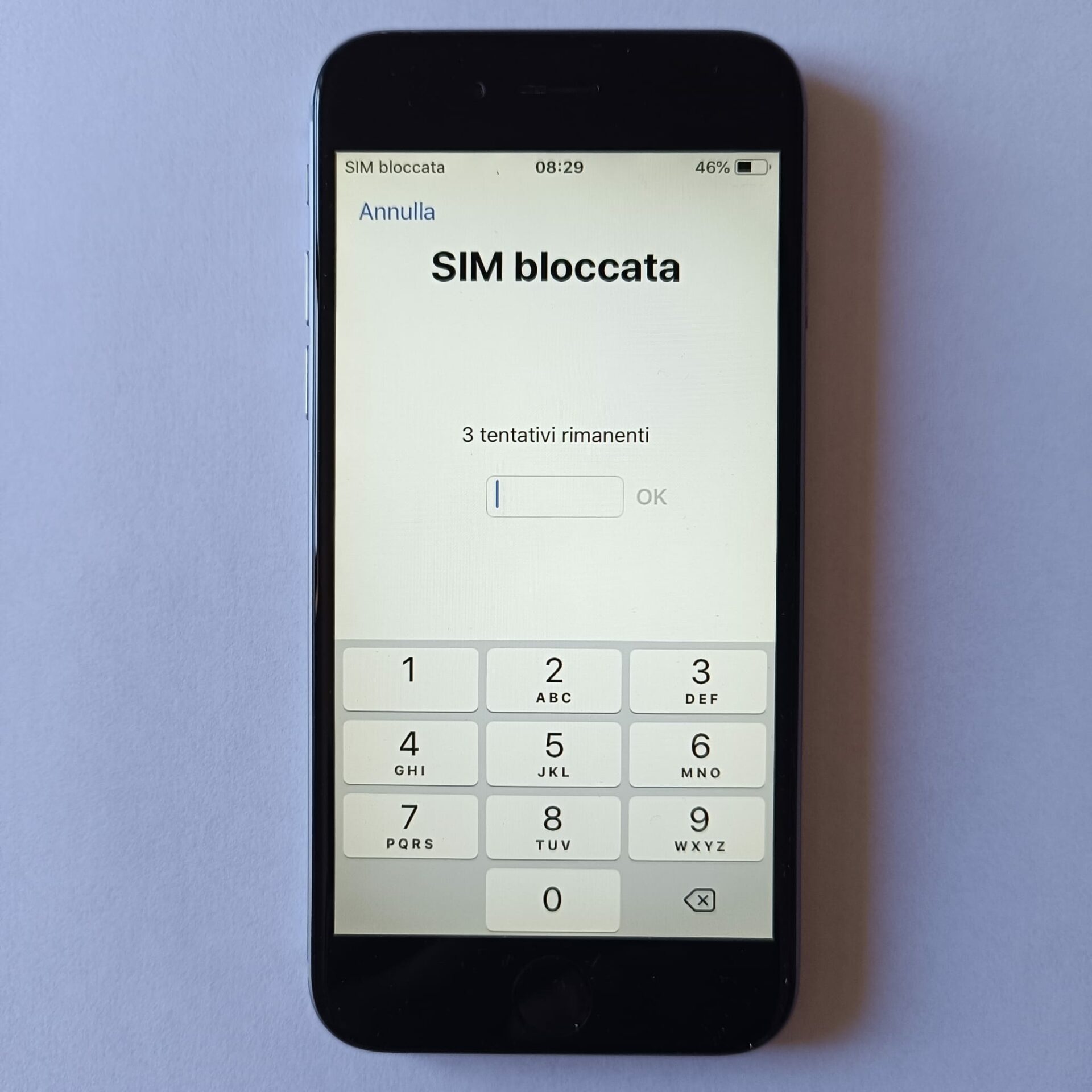 Qual è secondo voi l’aspetto più interessante o più delicato di lavorare su un podcast rispetto ad altre forme di giornalismo o intrattenimento?
Qual è secondo voi l’aspetto più interessante o più delicato di lavorare su un podcast rispetto ad altre forme di giornalismo o intrattenimento?
Francesco: Curando un podcast c’è un fattore chiave da tenere in mente: il podcast non impegna la vista, dunque la stragrande maggioranza di chi ascolta nel frattempo fa altro: si allena, cucina, si sposta… Per l’autore, la sfida – che trovo molto avvincente – è convogliare tutto il potere espressivo nell’unico senso dell’udito.
Digital Requiem è un documentario (che lo differenzia da altri generi di podcast come il talk o il podcast narrativo, ndr); qui è importante che la creatività sia al servizio della ricerca e del realismo. Le parole più sciolte delle interviste si accostano a quelle più calcolate della voce narrante, che definisce una cornice e tiene tutto insieme, trasporta da una stanza all’altra, chiarisce le parti più nodose e, quando serve, riepiloga. Dobbiamo fare attenzione a come pronunciare queste parole – timbri, ritmi, intenzioni – ma anche a non prevaricare gli altri suoni perché anche loro sono pieni di significato: gli inserti presi da trasmissioni TV, radio, video su internet, ma soprattutto la colonna sonora, che credo sia una delle cose più importanti.
Nicola: Prima di Digital Requiem avevo curato un podcast di lettura per una redazione bolognese, ma questo è il primo lavoro in forma di documentario. Da creatore e da ascoltatore, trovo che il podcast sia un mezzo potentissimo. Riesce a tenere alta l’attenzione anche di un pubblico molto giovane, offrendo un livello di approfondimento che altri formati, soprattutto più visivi o rapidi, faticano a garantire. Il suo aspetto più critico sta nella natura “multitasking” cui accennava Francesco: quando scrivi o monti un podcast devi sempre immaginarti in cuffia con l’ascoltatore, minuto per minuto, sapendo che basta poco per perderlo.
In più, credo che il podcast sia ancora un mezzo fertile per la sperimentazione. L’audio permette di osare, anche dal punto di vista produttivo, grazie a costi generalmente più contenuti. È uno spazio aperto a formati ibridi, dalla fiction al documentario, e a forme di storytelling molto creative.
Recentemente Rivista Studio ci ha ricordato che “i podcast stanno ai Millennial come i talk show stanno ai Boomer”, definendo i podcast come “il fast fashion della tv”. Viene effettivamente da interrogarsi sul modello di consumo del podcast come medium e sui suoi aspetti più interessanti o critici. Voi che ne pensate?
Nicola: Negli ultimi anni c’è stata una proliferazione di podcast che ha portato a una certa saturazione del formato. Alcuni contenuti sono pensati per essere veloci, leggeri, consumabili, e in questo senso il paragone con il fast fashion regge, la facilità di produzione e distribuzione ha abbassato la soglia d’accesso, ma probabilmente, a volte, quella della qualità. Detto ciò, credo che il podcast sia ancora un medium con enorme potenziale espressivo. Come detto prima è uno spazio dove si può sperimentare, approfondire, rallentare. Rispetto ad altri formati digitali, offre un’intimità e una profondità molto particolari: entri letteralmente nella testa dell’ascoltatore, spesso nei momenti più privati, mentre cammina, guida, si rilassa.
Francesco: La nostra cultura attuale ha sicuramente un grosso problema a convivere con il silenzio, la noia e l’astinenza da dopamina…e io ci sono dentro fino al collo! Ma è al contempo molto bello che chiunque abbia la possibilità di aprire con strumenti semplici ed economici uno spazio di condivisione del proprio pensiero. Questo consente a nuove voci di farsi da sole, e ha peraltro permesso a Digital Requiem di esistere: Nicola e io abbiamo trovato un editore presentandogli una demo audio fatta in casa con molta cura ma con una spesa economica irrisoria.
Con queste premesse, dico che i podcast sono già un prodotto di larghissimo consumo che si trova in un mercato già saturo di scelte. Ora, l’ascoltatore ha il sacrosanto diritto di ascoltare quello che gli pare; sta ai podcaster creare un rapporto di fiducia e stima con il pubblico e stimolare l’attenzione coltivando la qualità dei contenuti. Se l’utente si annoia, si confonde, non trova motivi per ascoltarti o si dimentica di te, è al 95% responsabilità del tuo lavoro. Per raggiungere qualità devi portare rispetto e cura per chi ascolta, metterti al suo servizio senza rinnegare i tuoi valori, devi studiare per raggiungere una competenza sui temi da affrontare ed esprimerli in modo agile e incisivo, nei giorni in cui non hai il naso chiuso. È altamente consigliabile conoscere il mezzo, quindi ascoltare tanti podcast per raccogliere stimoli, capire quali generi, tecniche e approcci ti saranno maestri, quali altri saranno perfetti esempi di come non vuoi lavorare, e quali ancora ti piacciono sì, ma consideri da rinnovare. Nel caso di progetti narrativi, serve quasi sempre molto tempo. Questo è il retroterra di Digital Requiem, che per due ore e venti di audio ha richiesto due anni di lavoro.
Penso che per chiunque voglia lanciarsi in questo mondo, questo mi sembra un buon momento. Vuoi che funzioni? Fatti una serie di scrupoli che ti aiuteranno ad appassionare, e soprattutto appassionarti: se non ti diverti non c’è ragione di farlo, e le orecchie se ne accorgono. Onore alle orecchie, e viva i podcast!
Condividi questo articolo