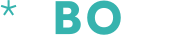Cosa evoca in noi la parola casa?
Per alcuni è un rifugio, per altri un confine. C’è chi la associa alla quiete, chi alla memoria, chi a un luogo da cui fuggire o a cui tornare. “Casa” è una parola che contiene mille significati: intimità, radici, protezione, ma anche trasformazione, perché ogni casa, come ogni vita, cambia con noi.

FK09.2004 di Mikael Olsson
L’etimologia del termine ci riporta al suo senso più originario: un riparo, qualcosa che difende dall’esterno e, al tempo stesso, traccia un confine tra un “dentro” e un “fuori”. È in questo spazio di passaggio, tra l’intimità e il mondo, che si muove Foto/Industria 2025 — la biennale internazionale di fotografia dell’industria e del lavoro promossa dalla Fondazione MAST di Bologna e curata da Francesco Zanot, giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Marsh Arabs Irak di Ursula Schulz Dornburg
Fino al 14 dicembre, la città torna a trasformarsi in un museo diffuso: dieci mostre distribuite in otto location del centro storico, a cui si aggiungono gli spazi del MAST, cuore pulsante della manifestazione (fino all’8 marzo 2026). Tutte sono dedicate a un unico tema, apparentemente semplice ma con molteplici sfaccettature e declinazioni: HOME. La casa concetto universale, ma che ci riguarda tutti, anche chi non ce l’ha o l’ha persa. HOME costituisce un nuovo capitolo dell’indagine di Foto/Industria sul rapporto tra fotografia, industria, lavoro e tecnologia, in cui opere e visitatori non solo occupano e condividono gli spazi, ma li abitano.
La casa, allora, non è soltanto un luogo fisico, ma una condizione mentale, un sistema produttivo, un simbolo culturale. È dove il mondo esterno entra nella nostra vita quotidiana e dove tecnologia, lavoro, memoria e immaginazione si mescolano.

Cleaner 01 di Kelly O Brien
Come nella psicoanalisi e nell’architettura — due discipline che, in modi diversi, si occupano del rapporto tra interno ed esterno — anche la fotografia diventa uno strumento per attraversare quel confine: per osservare ciò che accade dentro e fuori di noi.
E se l’industria ha costruito le città e le case in cui viviamo, la fotografia ci invita oggi a interrogarci su cosa significhi davvero abitare il nostro tempo.
Qui la nostra guida a Foto/Industria:
MAST
Jeff Wall – Living, Working, Surviving
Fino all’8 marzo 2026
La grande retrospettiva al MAST, sede madre della biennale, mette in dialogo la fotografia e il lavoro: la “casa” intesa come spazio della produzione e della sopravvivenza. I monumentali tableaux vivants di Jeff Wall, sospesi tra cinema e realtà, raccontano la quotidianità con una lucidità che svela l’umanità nei gesti più ordinari. È la mostra che riassume lo spirito di questa edizione: abitare come esperienza del mondo.
Palazzo Bentivoglio
Matei Bejenaru – Prut
Via del Borgo di San Pietro, 1
Il fotografo rumeno racconta la vita lungo il fiume Prut, che dal 2007 segna il confine tra Romania e Unione Europea. Nei suoi scatti, i villaggi che costeggiano le due sponde diventano metafora di un’Europa sospesa tra passato e cambiamento: un mondo rurale che resiste alle trasformazioni politiche, economiche ed ecologiche degli ultimi cinquant’anni.

Cârniceni di Matei Bejenaru.
Sottospazio – Palazzo Bentivoglio Lab
Forensic Architecture – Looking for Palestine
Via Mascarella, 2
Il collettivo londinese Forensic Architecture, nato alla Goldsmiths University, impiega l’architettura e le tecnologie digitali come strumenti di indagine su violazioni dei diritti umani e crimini di stato. Nel progetto Looking for Palestine ricostruisce, attraverso filmati, mappe, archivi fotografici e modelli virtuali, la distruzione di alcuni villaggi palestinesi avvenuta nel 1948, trasformando l’analisi spaziale in un potente atto di memoria politica e testimonianza civile. Un’indagine visiva sulle tracce di un popolo costretto all’esilio. La casa, qui, è il luogo negato, la prova da ricostruire, lo spazio politico della verità.

Forensic Architecture. Ricostruzione digitale delle abitazioni di al-Ma’in che vanno in fumo quando una milizia sionista attaccò il villaggio
Alchemilla / Palazzo Vizzani
Alejandro Cartagena – A Small Guide to Homeownership
Via Santo Stefano, 43
Frutto di una ricerca durata tredici anni, il progetto indaga gli effetti della suburbanizzazione che ha trasformato Monterrey negli ultimi decenni. In un percorso costruito come un ironico manuale per futuri proprietari, Cartagena smonta la retorica della casa come simbolo di sicurezza e progresso, rivelando invece le contraddizioni di una crescita urbana segnata da isolamento, consumo di suolo e disuguaglianze ambientali. Tra ironia e denuncia, riflette sull’ossessione contemporanea per la proprietà della casa. Le sue fotografie mostrano distretti residenziali, famiglie e automobili cariche di oggetti, in un paesaggio che mescola sogno americano e precarietà.

Carpoolers #10 di Alejandro Cartagena
Fondazione Collegio Venturoli
Via Centotrecento, 4
Julia Gaisbacher – My Dream House is not a House
Julia Gaisbacher dedica il suo progetto al complesso residenziale Gerlitzgründe di Graz, pionieristico esperimento di edilizia sociale partecipata ideato negli anni Settanta dall’architetto Eilfried Huth. Attraverso fotografie, film, materiali d’archivio e un modello architettonico originale, l’artista ricostruisce la visione di una comunità nata dal dialogo tra architetto e abitanti, dove progettare la casa significava immaginare insieme nuovi modi di vivere e condividere lo spazio.

My Dreamhouse is not a House di Julia Gaisbacher
Vuyo Mabheka – Popihuise
Con uno sguardo intimo e poetico, il giovane sudafricano ricrea gli spazi e i giochi, “popihuis”, della sua infanzia nelle township sudafricane. Le sue immagini – fatte di collage, disegni e fotografie – trasformano la memoria in architettura, restituendo un’infanzia segnata dalla povertà ma ricca di immaginazione e resilienza.

Emakhishini di Vuyo Mabheka
Mikael Olsson – Södrakull Frösakull

FK11.2002 di Mikael Olsson
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (Palazzo Paltroni)
Via delle Donzelle, 2
Sisto Sisti – Microcosmo Sinigo
Un viaggio nel dopoguerra attraverso l’obiettivo di Sisto Sisti, tecnico e fotografo per passione che ha documentato non solo il lavoro in fabbrica, ma la comunità che vi ruota attorno: famiglie, feste, orti, cinema, scuole e spazi condivisi a Sinigo, vicino Merano, tra gli anni Trenta e Cinquanta. In mostra oltre seicento immagini, selezionate da un archivio di tredicimila scatti, compongono il ritratto vivido di un piccolo mondo industriale diventato casa.

Festeggiamenti della Befana Fascista di Sisto Sisti
Spazio Carbonesi
Kelly O’Brien – No Rest for the Wicked
Via De’ Carbonesi, 11
La fotografa britannica porta a Bologna una riflessione toccante sul lavoro, la classe sociale e la rappresentazione. Attraverso immagini, testi e video, O’Brien costruisce un racconto sulla fatica invisibile e sulle eredità familiari, tra femminilità, cura e resistenza. La casa, qui, è il luogo del corpo e del riscatto.

Scrubber di Kelly O Brien
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Ursula Schulz-Dornburg – Some Homes, 1969–2002
Via delle Belle Arti, 56
In Some Homes, Ursula Schulz-Dornburg raccoglie sei serie fotografiche realizzate tra gli anni Sessanta e i Duemila in luoghi lontani tra loro – dall’Olanda all’Iraq, dalla Georgia all’Indonesia – per indagare l’idea universale dell’abitare. Le sue immagini raccontano dimore effimere costruite con materiali naturali accanto a strutture concepite per durare nei secoli, fondendo documentazione e riflessione concettuale. Dietro ogni casa, temporanea o monumentale, emerge la stessa urgenza: quella di proteggersi, riposarsi, conservare i propri beni e, insieme, di raccontare chi siamo attraverso ciò che costruiamo.

Bugis Houses, Sulawesi, Indonesia di Ursula Schulz Dornburg Bugis
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Moira Ricci – Quarta Casa
Via Don Giovanni Minzoni, 14
Quarta casa è la prima grande retrospettiva dedicata a Moira Ricci, che raccoglie venticinque anni di ricerca intorno a un tema centrale del suo lavoro: la casa come spazio di memoria, identità e appartenenza. Attraverso fotografie, installazioni e materiali d’archivio, l’artista intreccia autobiografia e collettività, restituendo la Maremma – sua terra d’origine – come luogo simbolico dove la vita privata si fonde con quella comunitaria. Pioniera nell’uso della fotografia familiare in chiave critica, Ricci trasforma ogni immagine in un dialogo sulla memoria, sulla cultura popolare e sulle tracce che lasciamo nei luoghi che chiamiamo “casa”.
(La mostra prosegue fino all’11 gennaio 2026.)

Dove il cielo è più vicino – Poderi #1 e Contadini #4 di Moira Ricci
In questa edizione, Foto/Industria ci invita a guardare la casa come specchio della società contemporanea — fragile, connessa, mutevole — e a interrogarci su cosa significhi davvero abitare oggi. Non è solo costruire, ma riconoscere: confini, assenze, relazioni che fanno di uno spazio, la nostra casa.
Dopo aver visitato le mostre, cosa rappresenterà per voi HOME?
Dettagli per le visite:
- Date: 07.11.2025 → 14.12.2025 (sedi diffuse) · MAST fino all’08.03.2026
- Accesso: gratuito (salvo diverse indicazioni in sede)
- Consiglio: partite dal MAST (chiave di lettura curatoriale), poi muovetevi in centro costruendo un percorso tematico:
- Casa come merce → Spazio Carbonesi / The Cool Couple / Fontcuberta
- Casa come memoria → Castore / Di Giovanni / Benassi
- Casa come progetto → Vitturi / Mastroianni / MF Giachino
- Casa come comunità → Elias Williams / Del Monte
Condividi questo articolo