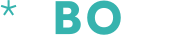In Italia, meno del 13% delle strade intitolate a persone porta il nome di una donna.
Lo spazio urbano è una forma di potere: chi lo disegna, lo nomina e lo abita decide anche chi può sentirsi sicurə, ascoltatə, visibile. L’Atlante di genere per una città femminista è un atto politico per cambiare questa geografia. Da dove si parte? Dall’ascolto di chi questo spazio lo attraversa ogni giorno, portandosi dietro il peso delle disuguaglianze.
Abbiamo intervistato Giulia Sudano, Valentina Bazzarin, Arda Lelo e Teresa Carlone, curatrici per Period Think Tank, per farci raccontare nel dettaglio il progetto dell’Atlante di genere di Bologna, realizzato insieme al Comune di Bologna e a Sex & the City. Un lavoro che è anche un libro, scaricabile gratuitamente con licenza Creative Commons.

Che cos’è l’Atlante di genere di Bologna? Lo potete riassumere in 6 punti significativi?
L’Atlante di genere di Bologna per una città femminista è molto più di una semplice fotografia dello stato attuale della città: è uno strumento di ascolto attivo e di indirizzo politico verso una Bologna più a misura di tutte le persone . Ecco, a nostro avviso, i suoi 6 punti chiave:
- Visione trasformativa: si ispira alle indicazioni di Leslie Kern ne “La città femminista”, proponendosi come guida pratica per ridisegnare gli spazi urbani con uno sguardo attento alle esigenze di tutte le persone .
- Strumento di cittadinanza attiva: raccoglie le richieste e i bisogni espressi direttamente da chi abita gli spazi urbani , invitando chi amministra la città a mettersi in ascolto e ad agire di conseguenza.
- Valutazione di impatto di genere delle politiche esistenti: offre una chiave di lettura critica sull’impatto delle azioni finora intraprese, suggerendo dove e come migliorare per ridurre disuguaglianze e discriminazioni e raggiungere l’equità di genere.
- Pluralità di voci: dà spazio a una molteplicità di esperienze — dal mondo associativo alla pubblica amministrazione fino alle singole persone — valorizzando il confronto e la collaborazione come motori di cambiamento.
- Spazializzazione dei dati: utilizza la rappresentazione geografica per evidenziare i luoghi, anche quelli considerati “minori” o meno visibili, dove occorre avviare o rafforzare interventi politici mirati.
- Riduzione delle disuguaglianze territoriali: si concentra sulla necessità di agire sui territori in modo capillare, riconoscendo l’importanza dei microluoghi e delle quotidianità urbane per costruire una città realmente femminista ed equa.
Come e perché nasce l’idea di un Atlante di genere di Bologna per una città femminista? C’è stato un episodio (o un’esigenza) che ha fatto scattare la scintilla?
L’idea dell’Atlante di genere di Bologna per una città femminista non nasce da un singolo episodio o da una scintilla improvvisa, ma si sviluppa in modo più strutturato, grazie all’opportunità offerta da un bando regionale vinto dal Comune di Bologna a inizio 2023. Questo ci ha permesso di esplorare nuove collaborazioni e di mettere a sistema metodologie di ascolto e di ricerca già sperimentate tra il 2023 e il 2024.
La collaborazione tra Period Think Tank e il Comune di Bologna ha radici più lontane: è iniziata nella primavera 2021, con un atto politico importante per noi, l’adesione del primo Comune in Italia alla nostra campagna “Dati per contare”. In quel momento, durante l’emergenza Covid-19, abbiamo capito quanto fosse cruciale disporre di dati disaggregati per genere, per orientare le strategie e la comunicazione pubblica, e soprattutto valutare le politiche pubbliche.
Nel 2022 questo percorso è entrato in relazione con la pubblicazione dell’Atlante di genere di Milano a cura di Sex and the City Aps. Questa esperienza, ci ha ispirate a immaginare un adattamento e un nuovo sviluppo a partire da quel modello alla realtà di Bologna in collaborazione con il Comune, che fra il 2022 e il 2023 ha realizzato anche le leMappe di genere della città di Bologna grazie a un finanziamento della Banca Europea degli Investimenti.
Così, su impulso del Comune e con un finanziamento dedicato abbiamo provato a restituire parte dei dati raccolti attraverso il bando regionale anche sotto forma di un Atlante, dando vita a uno strumento che non si limita a raccogliere dati, ma che costruisce un racconto corale e geograficamente situato dei bisogni, delle disuguaglianze e delle possibilità di trasformazione della città.

Ci sono stati dati o elementi che vi hanno sorpreso durante il lavoro?
Durante il lavoro, siamo rimaste profondamente sorprese dalla quantità e qualità delle informazioni raccolte attraverso le survey, i focus group e le interviste. Il primo elemento che ci ha stupito è stato proprio il grande livello di partecipazione: tantissime persone hanno mostrato un forte desiderio di raccontarsi, di collaborare e di trasmettere un messaggio chiaro all’amministrazione.
Attraverso le loro voci è emersa con forza l’idea che i bisogni in città sono differenziati, e che vanno letti con uno sguardo femminista e intersezionale, vale a dire attento all’insieme dei fattori che influenzano le esperienze delle persone e le opportunità a loro disposizione, come ad esempio classe sociale, provenienza, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità ecc.. Pur riconoscendo a Bologna una storica attenzione verso le persone più fragili, le testimonianze raccolte ci hanno mostrato come esistano ancora realtà invisibili agli occhi delle istituzioni, come l’aumento dei nuclei familiari monoreddito in cui la capo famiglia è una donna con figlie e figli o la necessità di migliorare le informazioni sui servizi a tutela della salute riproduttiva.
In che modo l’Atlante rende visibili dinamiche urbane che spesso restano invisibili? Potete farci un esempio concreto?
Analizzando ad esempio la graduatoria di accesso all’edilizia residenziale pubblica riferita all’anno 2023 con una prospettiva di genere, è emerso che le maggiori differenze si trovano nei nuclei familiari a 2 componenti in cui le donne hanno 15 punti percentuali in più degli uomini e a 5 componenti in cui, viceversa, gli uomini presentano 10 punti percentuali in più. Inoltre, il 94% delle richieste legate a situazione di monogenitorialità è rappresentato da donne, confermando la crescente fragilità economica in particolare di donne sole con figli e figlie di fronte a un mercato immobiliare sempre più inaccessibile.

Perché Bologna è un luogo fertile per un progetto di questo tipo?
Bologna è un luogo fertile per un progetto come l’Atlante di genere perché ha una tradizione consolidata di attenzione ai diritti, alla partecipazione e all’innovazione sociale. Esiste una rete viva di associazioni, cittadinə e istituzioni che lavorano quotidianamente per rendere la città più giusta , attenta alle differenze e capace di sperimentare nuove pratiche.
Un aspetto particolarmente importante è il modo in cui Bologna affronta il tema della sicurezza urbana: qui si riconosce che la percezione e l’esperienza della sicurezza cambiano tra il giorno e la notte, e si evita di cadere nella retorica securitaria, che rischia solo di polarizzare il dibattito, affrontando il tema in modo più olistico. Invece, l’approccio è quello dell’ascolto attivo delle richieste delle persone, indirizzando gli investimenti nei luoghi dove emerge un reale bisogno, e mantenendo forte l’idea che la sicurezza si costruisce prima di tutto attraverso la coesione sociale.
In questo contesto, l’Atlante si inserisce come uno strumento in grado di rendere visibili i bisogni differenziati e di orientare l’azione politica verso una città più equa e solidale.
Nonostante i dati sull’occupazione a Bologna siano tra i più positivi d’Italia, una lettura di genere mostra ancora grandi disuguaglianze. Quali sono, secondo voi, le principali criticità che restano da affrontare sul fronte del lavoro femminile e delle soggettività di genere nella nostra città?
Anche se i dati occupazionali a Bologna sono positivi rispetto alle medie nazionali,una lettura di genere mostra che le donne devono affrontare maggiori vulnerabilità: hanno una minore capacità di affrontare spese impreviste e sono meno presenti nel mondo imprenditoriale. Questo non per mancanza di competenze o iniziativa, ma perché spesso non possono permettersi né grandi investimenti né piccoli fallimenti, che invece fanno parte del rischio d’impresa. La disparità economica resta quindi un nodo cruciale, da affrontare con politiche che sostengano concretamente l’autonomia economica e la capacità di iniziativa delle donne e delle soggettività di genere. Ne è un esempio concreto il fatto che le donne si mostrano meno sicure degli uomini nella capacità di gestire un’improvvisa spesa di 2.000 euro: il 42,01% delle donne afferma di poter affrontare tale spesa, rispetto al 52,38% degli uomini.

In che modo il corpo è ancora oggi un campo di battaglia politico e culturale?
Il corpo continua a essere un campo di battaglia politico e culturale perché è ancora oggetto di controllo, giudizio e violenza. A Bologna, come altrove, lo vediamo nelle molestie di strada come il cat calling, nelle violenze verbali e fisiche che colpiscono in particolare donne migranti e donne velate, soprattutto sui mezzi pubblici, e nella mancanza di piena sicurezza sui diritti riproduttivi, ad esempio con l’accesso ancora complicato all’aborto farmacologico.
Anche il nostro questionario, che ha raccolto circa 3000 risposte, ha confermato quanto il corpo sia ancora un terreno di disuguaglianza, dove si intrecciano forme di discriminazioni diverse: genere, provenienza, condizione socio-economica. Riconoscere questa realtà è il primo passo per costruire una città che sappia davvero tutelare la libertà e la dignità di tutte le persone.
L’Atlante non è un punto d’arrivo, ma di partenza: quali sono i prossimi passi?
L’Atlante non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare a lavorare su dati, ascolto e politiche di cambiamento. Continueremo a collaborare con il Comune di Bologna all’interno del percorso “Dati per contare”, vigilando affinché gli impegni presi con questo percorso vengano mantenuti, trasformando le indicazioni raccolte in azioni concrete per una città davvero femminista.

Grazie alla collaborazione con l’ASL di Bologna, è stato risolto il problema dell’invisibilità anagrafica nei percorsi di screening. Come è nato questo progetto, e quali criticità ha affrontato per garantire l’accesso alla prevenzione sanitaria alle persone trans?
Nella pubblicazione, nel capitolo relativo alla rete dei servizi che garantiscono la sicurezza sanitaria alle cittadine e ai cittadini nella città di Bologna, è presente un’intervista a Maria Nobile de Santis, coordinatrice della rete dei consultori nell’AUSL Città di Bologna. Il progetto di collaborazione tra l’ASL di Bologna e il MIT (Movimento Identità Transessuale) nasce dalla volontà di affrontare la problematica dell’invisibilità anagrafica e di garantire l’accesso equo alla prevenzione sanitaria per le persone transgender, in particolare per quelle con genitali femminili. Fino a poco tempo fa, lo screening per il tumore del collo dell’utero era rivolto solo a chi aveva un’anagrafica femminile, creando esclusione per molte persone trans. Per risolvere questa difficoltà, è stato creato uno spazio dedicato presso il consultorio Reno, dove un operatore formato esegue il PAP test in un ambiente privato e accogliente. Questa iniziativa, che ha visto una stretta collaborazione con le associazioni, è stata un passo importante, non solo a livello regionale, ma anche nazionale.
Per quanto riguarda i percorsi specifici di prevenzione per le persone in transizione dal sesso maschile a quello femminile, al momento non esiste una versione specifica, ma l’ASL sta lavorando per riorganizzare il servizio in questa direzione, con l’intento di rendere il trattamento delle persone transessuali sempre più comune e normalizzato all’interno dei consultori. Sebbene la partecipazione al servizio sia ancora limitata, ci aspettiamo che aumenterà con il tempo, e sono previsti anche esami di secondo livello per gestire eventuali positività.
Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso una sanità attenta alle esigenze di tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità di genere.
Bologna è spesso citata come un modello atipico nella gestione del sex work. In che modo la collaborazione tra istituzioni pubbliche, terzo settore e realtà come il MIT ha contribuito a sviluppare un approccio centrato sui diritti e sulla salute delle sex worker, in particolare migranti e transgender?
La cultura politica delle istituzioni pubbliche, incentrata sul riconoscimento delle soggettività e dei diritti di tutte le persone, e la presenza del Movimento Identità Trans (MIT) hanno contributo, a partire dagli Novanta, a rendere Bologna un’eccezione sul piano nazionale rispetto alla governance dei fenomeni della prostituzione e del lavoro sessuale (sex work). Nonostante la diversità di visioni su prostituzione e lavoro sessuale fra chi la considerava una forma di violenza e chi un’attività lavorativa legittima, si riuscì a trovare una convergenza nella lotta alla tratta grazie a visioni condivise sulla complessità delle esperienze delle donne migranti, dando vita alle unità di strada. Il Comune di Bologna, parte di una strutturata rete regionale e in sinergia con il privato sociale, l’associazionismo, il volontariato e altri enti pubblici, è impegnato sui fenomeni della prostituzione, degli sfruttamenti e delle tratte da quasi 30 anni. Il scopo delle unità di strada è ancora quello di promuovere l’accesso al sistema sanitario e ai servizi di welfare per le donne cisgender e transgender migranti che fanno lavoro sessuale in strada, nonché per promuovere la fuoriuscita dalla rete della tratta per coloro che si trovano in situazioni di grave sfruttamento. Il Comune di Bologna nel programmare le sue attività ha sempre mantenuto il dialogo con realtà come il MIT, che hanno un approccio basato sulla riduzione del danno e sulla centralità del benessere e dei diritti delle persone che praticano sex work. La sfida per le istituzioni è ora rispondere alle nuove tipologie di bisogni legati alle trasformazioni in corso, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni di sex workers nella co-progettazione delle politiche che le riguardano.
Condividi questo articolo